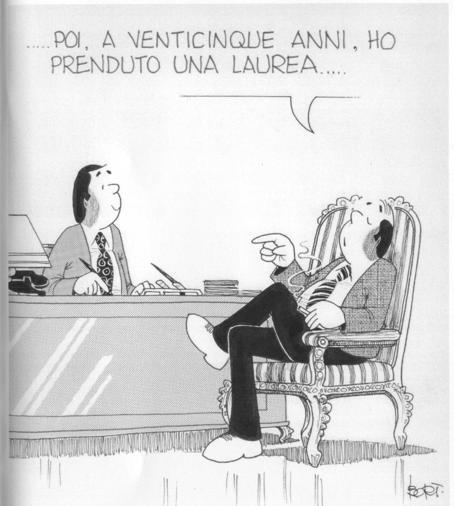Vidi così arrivare improvvisamente a tutta forza i grossi sassi – o piccoli massi – che colpirono quasi contemporaneamente il parabrezza. Da un istante all’altro risultai iscritto al club più numeroso dell’ex URSS: quello dei proprietari di parabrezza crepati, stile “vetrina del gioielliere dopo rapina con la mazza”. In realtà c’era poco da scherzare: il prossimo volo di rondini, e mi sarei trovato senza vetro e col vento in faccia.
Vidi così arrivare improvvisamente a tutta forza i grossi sassi – o piccoli massi – che colpirono quasi contemporaneamente il parabrezza. Da un istante all’altro risultai iscritto al club più numeroso dell’ex URSS: quello dei proprietari di parabrezza crepati, stile “vetrina del gioielliere dopo rapina con la mazza”. In realtà c’era poco da scherzare: il prossimo volo di rondini, e mi sarei trovato senza vetro e col vento in faccia.
Riaccesi il motore, rigirai la macchina verso ovest e partii di gran carriera, a non più di dieci chilometri l’ora. Il motore faceva rumori inquietanti, come se – per assurdo – i pistoni e l’albero stessero litigando ferocemente con della sabbia (sabbia? che idea balzana! ma non era roccioso, ‘sto dannato deserto?). Mi mancavano almeno venticinque chilometri per raggiungere il margine occidentale del Barsuki, dove cominciavano le montagne.
Più andavo avanti, più la storia della sabbia sembrava disturbare il mio motore. Dopo qualche altro chilometro, la macchina si fermò. Il vento no. Il flemmatico Larson a questo punto avrebbe ammesso di sentirsi a disagio, io invece preferivo definirmi nella merda fino al collo. Aspettai un paio di minuti, sperando che tra l’auto e il vento ci fosse una specie di patto: “tu mi fai fermare, così dimostri quanto sei forte, poi però mi lasci in pace”. Invece il protocollo d’intesa non sembrava essere stato siglato, e la bufera decise che non si accontentava di vincere, ma voleva trionfare. Non potevo giudicare né oggettivamente né tantomeno in serenità d’animo la forza delle raffiche, ma in base alla mia esperienza di città ventose (e ne avevo) stimai che non potevano essere inferiori ai duecento chilometri l’ora, in aumento.
Molto preoccupato, provai a riaccendere il motore, e quello partì. Avanzai pianissimo, tanto che il tachimetro non si spostava, limitandosi a vibrare impercettibilmente. Il rumore che riusciva a filtrare dall’albero di trasmissione mi suggeriva che la Lada tra poco sarebbe stata da rottamare, cosa che personalmente pregavo avvenisse il più tardi possibile. Tenevo gli occhi incollati non sul fondo del deserto (inutile), bensì sul contachilometri, così quando il motore abdicò sapevo che mancavano ancora tre chilometri almeno alle montagne.
Cosa potevo fare? Per prima cosa misi le cassette con le provviste e le latte di benzina contro i finestrini che ricevevano le raffiche, quindi telefonai a Larson. Non c’era. Lasciai alla segreteria un messaggio che mi auguravo non suonasse troppo allarmato, ma che in ogni caso descriveva efficacemente la situazione.
Le casse mi salvarono dalle schegge di vetro, quando i due finestrini di sinistra si ruppero contemporaneamente, mentre l’auto già beccheggiava paurosamente per conto suo. In pochi secondi il vento spostò le casse, e mi dovetti appoggiare con la schiena contro di esse per non esserne travolto anch’io. L’interno della Lada si stava rapidamente trasformando in una versione ridotta della bufera: ridotta in senso dimensionale, non riguardo alla forza.
Incredibilmente non ero preoccupato per la mia incolumità, ma capii che avevo ormai perso la battaglia. Non riuscivo a credere che il Barsuki avrebbe avuto le mie ossa, ma mi riusciva facile pensare che mi aspettava una camminata di almeno cento chilometri, per arrivare dove Ahmanov mi aveva lasciato.
Cominciai a temere per la mia vita solo quando la macchina si sollevò una prima volta, di almeno trenta gradi. Dopo il contraccolpo, decisi che avevo visto abbastanza e provai a scendere. Idea sbagliata. Le frustate che presi in faccia mi fecero cambiare subito piano. Risalii in macchina.
Per prima cosa, abbassai i finestrini di destra. Quindi, con grande sforzo, buttai le casse dai finestrini già sfondati di sinistra. Infine mi distesi sui sedili e mi raggomitolai in tutto il materiale morbido e non spigoloso che c’era a bordo.
Ora il vento incontrava meno resistenza, e il suo stesso flusso all’interno dell’abitacolo contribuiva a stabilizzare la macchina: era come una corda tesa dal lato guida a quello passeggero, che entrava e usciva dai finestrini. Se l’auto si fosse rovesciata su un fianco, avevo sempre un lato da cui scappare; se si fosse messa addirittura sottosopra, ne avrei avuti due.
Il vento decise di sperimentare subito la prima alternativa. Mi trovai così in piedi, in una posizione non solo scomoda ma soprattutto molto precaria: la Lada poteva cappottare in qualsiasi momento. Quando il tetto cominciò a deformarsi sul lato destro, capii che il pericolo era serio, ma non avevo alternative. Dopo pochi secondi, la macchina si cappottò.
Aprii all’istante la portiera del guidatore, che aveva assorbito tutto il vento ma era ancora intatta (a parte le ammaccature), e sgusciai fuori. Ora potevano succedere due cose: o la macchina si metteva a girare su se stessa facendo perno sul tetto, o questo non resisteva al peso della scocca e si accartocciava a terra.
Fui molto fortunato: in pochi secondi parabrezza e lunotto esplosero sotto la pressione, e motore e scocca schiacciarono definitivamente l’abitacolo. Perfetto: non potevo chiedere di più. Adesso avevo una specie di masso, del peso di una tonnellata, saldamento posato al suolo. Mi rannicchiai quindi contro l’insolito riparo, verificando subito che – paradossalmente – mi trovavo molto più al sicuro di mezz’ora prima.
Erano le nove di sera. Alle nove e mezzo il vento cominciò a rallentare. Alle dieci era ancora forte, ma non più pericoloso.
Con una freddezza di cui ero il primo a stupirmi, avevo passato quel tempo ad immaginare il mio ritorno a piedi verso Turgaj. Potevo prendere la strada più diretta, tracciando una linea da dov’ero fino al bordo settentrionale del deserto, oppure farmi i restanti tre chilometri verso ovest, e quindi costeggiare le montagne. Optai per la seconda soluzione, che aveva il vantaggio di offrirmi la prospettiva di un qualche riparo dal sole, almeno nel pomeriggio. Intanto, dove avrei trascorso quella notte?
Decisi di incamminarmi subito verso le montagne perché – se la mappa era precisa e avevo fatto bene i calcoli su dove esattamente mi trovavo – proprio in linea retta verso ovest c’era una specie di gola che, nel caso il vento ci avesse ripensato, garantiva un riparo molto più solido dei resti della Lada. Verso mezzanotte ero all’imbocco del canalone, e dopo altri dieci minuti di marcia ero completamente al riparo dal vento, che si era stabilizzato su standard accettabili (almeno rispetto alle performance della giornata).
Non ero stanco, ero distrutto. Avevo tutto l’equipaggiamento comprato con Dino, ma nient’altro. La situazione si presentava indubbiamente difficile, ma considerato il GPS, il telefono satellitare e le provviste, tutt’altro che disperata. Ebbi anche la forza di pensare che non era nemmeno necessario farsi tutto il deserto a piedi: disponendo di un mezzo più adatto del catorcio di Ahmanov, qualcuno poteva venire a prendermi anche fino a dov’ero.
Prima di addormentarmi come un sasso, ebbi un ultimo pensiero: e l’altalena?