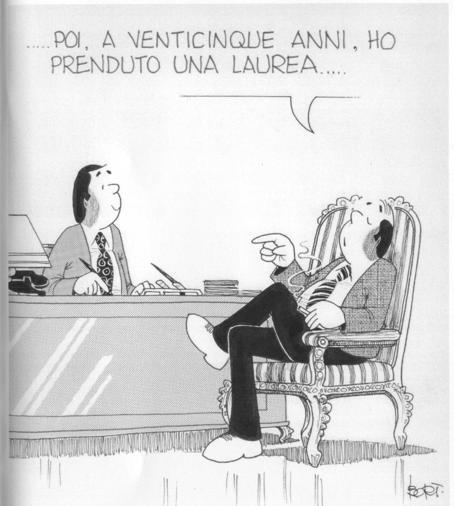Mi guardai intorno. Ero in Siberia, e si vedeva. Un invisibile filo logico e ideologico legava indissolubilmente il tavolinetto di betulla, sul quale era posato un vasetto da fiori senza fiori, alla polvere di Akademgorodok. Credetti in quel momento di capire veramente di che cosa era fatta l’amicizia tra Anatolj e il professore: esperienze sensoriali comuni. Lì, ad Irkutzk, entrambi avevano avuto negli occhi i medesimi mobili, gli stessi accostamenti indecisi di colori indecifrabili, la stessa dignitosa essenzialità che contraddistingueva l’ambiente quotidiano di un accademico in pensione e di un funzionario statale di medio livello. I due dovevano aver compiuto i medesimi gesti nel preparare il the, nel lavare le tazzine, nel combattere col televisore antiquato, anche se fisicamente erano separati da qualche strada (Blocco L per l’uno, Blocco K per l’altro); dovevano conoscere entrambi molto bene la pressione delle molle contro il sedere, che oltre l’imbottitura ormai consumata dei divanetti insidiavano oltraggiosamente le terga di rispettabili iscritti al partito (al momento, veramente, stavano insidiando le mie); dovevano sapere entrambi che il sole che sorgeva ogni mattina era forse quello dell’avvenire, ma dell’avvenire di qualcun altro, non più del loro. Kvitko e Akundjanov erano uguali perché così li aveva modellati il loro mondo, e la pensione aveva finito per completare l’opera: li aveva resi identici.
Mi guardai intorno. Ero in Siberia, e si vedeva. Un invisibile filo logico e ideologico legava indissolubilmente il tavolinetto di betulla, sul quale era posato un vasetto da fiori senza fiori, alla polvere di Akademgorodok. Credetti in quel momento di capire veramente di che cosa era fatta l’amicizia tra Anatolj e il professore: esperienze sensoriali comuni. Lì, ad Irkutzk, entrambi avevano avuto negli occhi i medesimi mobili, gli stessi accostamenti indecisi di colori indecifrabili, la stessa dignitosa essenzialità che contraddistingueva l’ambiente quotidiano di un accademico in pensione e di un funzionario statale di medio livello. I due dovevano aver compiuto i medesimi gesti nel preparare il the, nel lavare le tazzine, nel combattere col televisore antiquato, anche se fisicamente erano separati da qualche strada (Blocco L per l’uno, Blocco K per l’altro); dovevano conoscere entrambi molto bene la pressione delle molle contro il sedere, che oltre l’imbottitura ormai consumata dei divanetti insidiavano oltraggiosamente le terga di rispettabili iscritti al partito (al momento, veramente, stavano insidiando le mie); dovevano sapere entrambi che il sole che sorgeva ogni mattina era forse quello dell’avvenire, ma dell’avvenire di qualcun altro, non più del loro. Kvitko e Akundjanov erano uguali perché così li aveva modellati il loro mondo, e la pensione aveva finito per completare l’opera: li aveva resi identici.
Guardando fuori dalla finestra, provavo un senso di estraniamento, forte ma non spiacevole. Tre giorni prima ero tra papere e mirtilli, ora stavo in una gigantesca scatola da scarpe munita di finestre, in mezzo ad altre decine (centinaia?) di scatole uguali, ospite occasionale di un orso in disarmo. Come avevo fatto, ad arrivare lì? In realtà, al giorno d’oggi queste cose erano semplici, ormai: bastava avere soldi da buttare, una decisione al limite della sconsideratezza, niente di meglio da fare. Se però mi mettevo a pensarci con impegno, notavo che il confine tra il sentirmi un eroe coraggioso o un viziato coglione era molto labile. Riflettevo anche che era bastata una telefonata di Larson per farmi saltare senza indugio dalla quiete vacanziera a un frenetico spostarmi per aeroporti. A cercare cosa? Fantasmi. Se era bastato tanto, voleva dire che non c’era niente di abbastanza solido e pesante da tenermi fermo. In definitiva, ero una specie di foglia al vento. E che fanno le foglie, nel vento? Che domanda!….Volano.
Quando Anatolj tornò dalla cucina con la versione definitiva del mio the (zucchero? limone? latte? in Russia non è uso chiedere: si beve quello che ti portano) mi apprestai ad ascoltarlo, ma soprattutto a capirlo.
Compresi presto che Kvitko ci era rimasto molto male, quando il professore era sparito, non spiegandosi né l’ipotesi di suicidio né quella di un improvviso e repentino abbandono della sua vita di pensionato. Con tutta evidenza, Akundjanov era una persona di cui lui conservava un ottimo ricordo. In poche ore di conversazione, Anatolj fu particolarmente convincente su di un punto: la buona salute sia fisica che mentale di Akundjanov fino a poco prima della scomparsa. Non mi convinse la sua volontà di persuadermi, ma proprio il contrario. Kvitko non si sforzava in alcun modo di portarmi a credere alla normalità del professore: raccontava solo con semplicità e schiettezza quello che aveva visto e interpretato. Era naturale, calmo e tranquillo, nonostante i modi un po’ rozzi.
Il giorno dopo, riaccompagnatomi all’aeroporto, Kvitko mi salutò quasi con le lacrime agli occhi. Sapevo che non erano per me, quelle lacrime, ma per Akundjanov. E la cosa non poteva non farmi riflettere, così come il fatto che Kvitko non mi avesse chiesto un soldo, né per l’ospitalità né per il disturbo. Un vecchio russo, indubbiamente. Di quelli che raramente parlano a vanvera.
Il forte impatto dell’incontro con Anatolj aveva portato le mie indagini a una svolta inaspettata: se Akundjanov non era pazzo (e ora ero disposto a crederci anch’io), perché aveva scritto un articolo completamente assurdo? Se non era psicologicamente e emotivamente fragile, come aveva potuto razionalmente credere alle relazioni fattegli dai pastori? E se non aveva rinnegato la propria linea di ricerca, perché – una volta in pensione – non ne aveva mai fatto neanche argomento di confidenze davanti al caminetto?
Durante il viaggio di ritorno, mi sforzai di fare per l’ennesima volta il punto della situazione. Mi chiesi anche se in definitiva il pazzo non ero io, in fondo: stavo tornando dall’Asia centrale, con mezza Mongolia più a ovest di me, solo per aver voluto parlare dello stato di salute di un tizio morto trent’anni prima. Ancora una volta, come il giorno prima, mi chiesi se proprio non avevo altri modi per spendere i miei soldi e il mio tempo. E dietro a tutto questo, cosa c’era? Non il tesoro di Tutankamon, ma un’altalena. Ragionai anche su di un altro fatto: se l’avessi finalmente trovata, questa benedetta altalena, magari perché qualcuno me l’aveva messa di notte in giardino, la mia ricerca sarebbe finita. E davanti alla prospettiva di averla infine trovata, avrei necessariamente dovuto fare un bilancio di costi e ricavi. Sarei stato messo di fronte al fatto nudo e crudo: avevo passato tre anni e mezzo correndo dietro a un giocattolo gigante. Capivo che sarebbe stato meglio scoprire che Akundjanov era un pazzo scatenato, che buttava i mobili in strada in preda a crisi di schizofrenia. Così, invece, il bilancio sinora nettamente a favore della tesi “sono tutte balle” si era in sia pur piccola parte riequilibrato a favore del “magari qualcosa di vero c’è”. Quindi sarebbe stato più difficile decidersi a mollare tutto (già da tempo avevo smesso di parlarne ai miei conoscenti e colleghi: mica potevo dire loro che andavo in giro per il mondo a cercare notizie del giocattolo di Polifemo, no?).
Ma – ancora una volta – sentii dentro di me che non c’era niente da fare: la storia non poteva finire così. Se mi conoscevo un minimo, ero di nuovo in trappola. Non mi ero fermato fino ad ora, non mi sarei fermato adesso, dopo Irkutzk, per quanto assurdo ed evanescente fosse l’obiettivo.
Era prima di tutto una questione di principio, certo, ma non solo. All’inizio mi ero dato da fare un po’ per l’indubbio fascino in sé di un oggetto come la grande altalena, un po’ per “recuperare” – come direbbe uno psico-sociologo nella sua rubrica su un settimanale illustrato – i ricordi della mia infanzia. Ma poi, durante e dopo Akademgorodok, la cosa si era trasformata in una personale sfida contro i mulini a vento. Ed era questo a rappresentarmi bene, molto più dei mulini stessi: ero in corsa perché mi piaceva correre. Se era scritto così, avrei finito per sacrificare la mia vita per un’altalena. E fosse.
Mi vedevo a consumarmi fino alla fine dei miei giorni a rimestare l’acqua nel mortaio, magari finendo – una volta pensionato – divorato dai corvi dopo un colpo di sole in qualche deserto tra l’Ustjurt e gli Altai. Ma ogni volta che pensavo all’assurdità di questa possibilità, mi tornavano in mente le altalene di Piazzale Rosmini, con il loro mistero.
Per accantonare i risvolti psicodrammatici delle mie scelte, dallo scalo di Mosca mi concentrai nuovamente sui fatti. Avevo verificato fino in fondo tutte le variabili in gioco? Ovviamente no. Alcune erano inverificabili, come ad esempio rintracciare i pastori (che sarebbe stata la cosa più utile). Altre richiedevano l’assunzione di ipotesi di lavoro che equivalevano a professioni di fede. Altre ancora erano oggettive, ma non nell’interpretazione (l’articolo era un pesce d’aprile o no? e se no, fino a che punto?). Cosa potevo ancora effettivamente controllare?
Ero ormai in volo sull’Adriatico, quando mi illuminò la risposta all’ultima domanda: gli altri due articoli. Dovevo verificare se questi veramente non c’entravano niente con “Velikie kacheli”. Era un impegno di tipo desk, preferibilmente da delegare a chi fosse più competente di me.