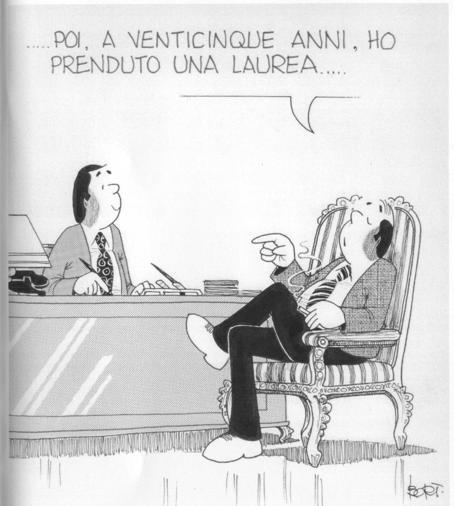Per un paio di giorni convissi con questo piccolo fastidio che mi ronzava dentro, poi non ce la feci più, e decisi di verificare per altra strada. Se avessi scoperto che il grand’uomo aveva inteso proprio la suthat, l’avrei aspettato sotto casa sua con una mazza ferrata, altrimenti gli avrei chiesto ulteriori informazioni sull’altalena numero 2. Chiamare io direttamente l’intrattenitore da feste mi orripilava, anche perché durante il nostro casuale incontro non avevo fatto nulla per nascondergli che la sua semplice esistenza mi risultava molesta, ma il mio ferito senso estetico esigeva una risposta immediata.
Per un paio di giorni convissi con questo piccolo fastidio che mi ronzava dentro, poi non ce la feci più, e decisi di verificare per altra strada. Se avessi scoperto che il grand’uomo aveva inteso proprio la suthat, l’avrei aspettato sotto casa sua con una mazza ferrata, altrimenti gli avrei chiesto ulteriori informazioni sull’altalena numero 2. Chiamare io direttamente l’intrattenitore da feste mi orripilava, anche perché durante il nostro casuale incontro non avevo fatto nulla per nascondergli che la sua semplice esistenza mi risultava molesta, ma il mio ferito senso estetico esigeva una risposta immediata.
Per non sembrare troppo scemo, mi feci aiutare dalla mia amica-ospite. Le telefonai e la istruii: sarebbe stata lei a chiedergli, fingendosi interessata in prima persona, dove aveva sentito lui la storia, e che altro ne sapeva. Dopo qualche giorno, la mia complice mi chiamò. Missione compiuta. Il viaggiatore era in realtà un giornalista (dio mio!) che si “dilettava di studi sociali e etnologici” (diomio diomio!), tanto da mandare al diavolo la carriera per passare invece nove mesi all’anno nei luoghi più improbabili, ove sbarcava il lunario scrivendo reportage “di colore”. La storia dell’altalena l’aveva sentita in Iran, ma gliel’aveva raccontata un vecchio usbeko, secondo il quale l’altalena non necessariamente esisteva veramente, bensì simboleggiava qualcosa per le popolazioni animiste del Turkestan. Questo era tutto. Ringraziai e riappesi.
Turkestan? Era evidente che l’usbeko e quindi il giornalista parlavano proprio di un’altra altalena: tra Usbekistan e Siam ci sono poche connessioni, sia geografiche che religiose, e se esisteva un oggetto così particolare in Thailandia, ne poteva benissimo esistere un altro in Asia centrale.
Strano a dirsi, ma la nuova prospettiva mi confortava: ritrovarmi al punto di partenza era meglio che aver preso il sentiero sbagliato. Nulla era compromesso. Quello stesso giorno ripresi su internet la mia ricerca, che cominciava ad assomigliare ad una sfida. Ma dopo ben tre sere trascorse a girare invano, mi dichiarai sconfitto: evidentemente l’oggetto misterioso era tale anche per internet. La pista si era esaurita, le altalene anche. Pace.
Passarono altri mesi di relativa tranquillità interiore (almeno rispetto alle altalene), al termine dei quali conobbi per caso un tizio che aveva appena brevettato un motore di ricerca innovativo. Dopo un paio di settimane di incontri di lavoro, gli chiesi se non potevo fare una prova di potenza del suo motore, cercando cose inusuali. Naturalmente volevo testare il software sulla grande altalena, quella introvabile. Così gli feci visita al laboratorio, e lui alla mia insolita richiesta cominciò a digitare e digitare… Trovammo la suthat di Bangkok in tutte le salse possibili, ma sempre e solo lei. Insistemmo, ma sia il magico motore di ricerca che il web sembravano aver già dato tutto. La mia guida si incaponì, a forza di cercare senza trovare niente: oltre a sfidare me, ora l’altalena stava sfidando anche lui, e per giunta sul suo terreno.
Dopo più di tre ore di ricerche sempre più sofisticate e tangenziali in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo, colto da disperazione calai le mie ultime carte: iniziammo a provare con le traslitterazioni in caratteri latini di “altalena” in cinese e in russo. Comparvero oscillanti bambini russi e cinesi, esattamente come finora ne erano comparsi di europei e americani; prendemmo visione degli aquasplash di tutta l’Asia… Solo a notte inoltrata, quando la vigilanza del razionale e del ragionevole si fa più blanda, in un sito russo trovammo finalmente una traccia di quello che sembrava essere un altro giocattolo cresciuto troppo. Click.
Sotto i nostri occhi comparve istantaneamente una semplice pagina di testo, divisa in tre colonne: titolo/autore/anno. Con tutta evidenza si trattava di un elenco di pubblicazioni. Cercammo la nostra parola-chiave nella pagina: c’era un solo riferimento. “Velikie kacheli”, pubblicato nel 1968 da tale S.G. Akundjanov. Nient’altro.
Provammo a risalire lungo l’albero della pagina, ricevendo in risposta solo il frustrante “Directory denied”. Per uno dei tanti e frequenti misteri di internet, avevamo l’informazione a valle ma non potevamo accedere a quella a monte. Poco male: in testa alla pagina c’era una specie di riferimento generale: “Bibliotekij Akademgorodoka”. Le biblioteche di Akademgorodok.
Molti altri a questo punto si sarebbero detti “embè?” e avrebbero tirato dritto, ma io no. Quella scarna pagina mi interessava per almeno due motivi. Innanzitutto il titolo stesso. Col motore noi stavamo cercando “kacheli” (altalena) dopo aver tentato inutilmente “bolshie kacheli” (grande altalena). Avevamo trovato invece un’altalena “velikie”, cioè grande in senso non solo fisico, ma quasi morale. In italiano si poteva rendere con il termine “potente” (o “eminente”). Ciò la poneva in una luce del tutto diversa da quella dei giardini e degli aquasplash.
La seconda cosa che mi colpiva era che l’articolo fosse stato pubblicato ad Akademgorodok, e non a Mosca o Leningrado. Akademgorodok era un luogo di cui avevo già letto qualcosa in precedenza, e che si poteva definire come il cimitero degli elefanti della scienza staliniana. Lì – mi pareva di ricordare – negli anni ’40 e ’50 il Piccolo Padre aveva finanziato ricerche eterodosse, probabilmente nel tentativo di cortocircuitare i tradizionali percorsi scientifici, per giungere per vie traverse a scoperte equivalenti o superiori a quelle in atto in Occidente, ma con un costo irrisorio rispetto a queste ultime. Il tentativo era fallito del tutto, ma ciò aveva prodotto una concentrazione di menti notevoli (sia pure venate di follia) in un singolo punto della Siberia meridionale.
Facendo associazioni mentali indebite spesso si rischia il fosso, ma era proprio in base ad esse che ora vedevo formarsi un legame virtuoso tra la mia personale idea di altalena, l’altalena dell’usbeko e il “marchio di qualità” targato Akademgorodok: ora avevo ben due punti a solleticare il mio interesse, che era e rimaneva di carattere fortemente estetico. Naturalmente – poiché ammetto di essere pazzo, ma non anche babbeo – prima di lanciarmi contro i mulini a vento dovevo verificare attentamente entrambi.
Così ringraziai il mio traghettatore nelle acque del virtuale e me ne tornai a casa, a riflettere.