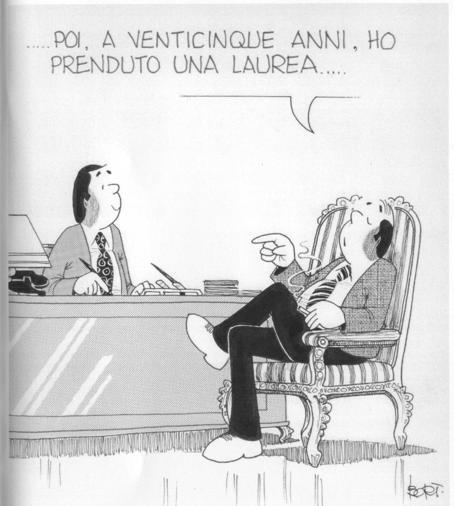Ci sono compagni di classe speciali, anche in una classe di per sé speciale. Uno di questi era Marco “Oscar Robertson” Zennaro, il ragazzo che sapeva sempre sorridere. Anche quando si ruppe una gamba a Lavarone, e io che lo prendevo in giro perché gli avevo detto che non sapeva sciare. Guardava il lato buono delle cose, ma non era uno che si tirasse indietro se c’era da farsi valere. Un gruppo di noi andava spesso a Sant’Elena a giocare a pallacanestro su un campo in cemento. Percorrevamo tutta la città, da Rio Marin. E quella volta che chi già stava sul campo ci disse che non ci cedevano un canestro, Marco non fece una piega: saltò addosso all’ambasciatore di sventura e, una volta appurati i nostri diritti, tornò a sorridere come nulla fosse successo. Potere dei rapporti tra tredicenni.
Marco fui il primo che incontrai alla cena del 2013: lo vidi attraversare campo San Polo e sedersi sulla panchina dove stavo. Quella volta non sorrise, ma ci facemmo una sonora e fraterna risata: “Solo tu, potevi essere” – “Anche tu“. Da quella sera non ci siamo più visti, con la certezza che sarebbe risuccesso un giorno o l’altro. Non succederà. Io lo so, lui spero non lo scopra mai.
Non abbiamo mai litigato, non ci siamo mai scazzati per nessun motivo. Era un buon amico di scuola, era un buon amico tout court.
Se penso a lui, mi viene in mente un Voit che rimbalza per le calli e i campielli sulla strada per Sant’Elena, contenti di andarci insieme e contenti di sapere che insieme saremmo ritornati.
Alla cena ci disse “Siete arrivati voi e c’è di nuovo qualcuno che mi riconosce, che sa dirmi dove sto di casa“. Era il miglior riassunto del significato di quella serata.
Sì, Marco, sapremo sempre dove abiti, sempre ti riconosceremo ovunque tu vada.