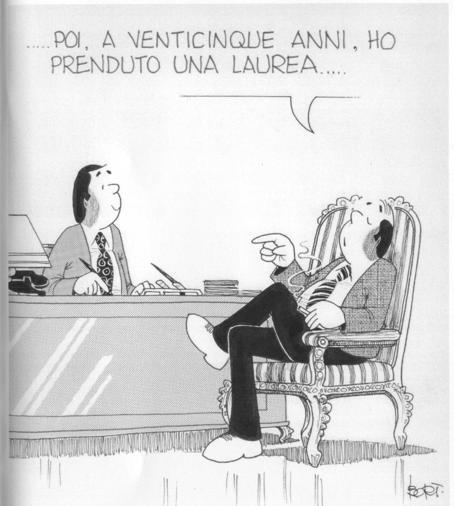La lettera era arrivata il 2 o 3 gennaio, in ritardo secondo quanto prevedeva la legge, per cui – assai teoricamente – sarei dovuto risultare automaticamente libero da ogni obbligo militare. Ma ero così contento di avere uno scopo, una prospettiva precisa, che non mi sognai nemmeno di obiettare: la Scuola di Artiglieria mi attendeva il 17. Al concorso (a Verona) ci avevano detto che i migliori erano destinati all’Artiglieria o al Genio. Mi sembrava giusto: sulle 67 domande del test ne avevo sbagliato solo una (per tremenda ironia, quella di Fisica: mi sarei preso a martellate in testa).
La Scuola era a Bracchausen, il che significava due cose: 1) la villa del fine settimana dei miei zii; 2) la vaga possibilità di rivedere una certa ragazza romana con cui ero stato in vacanza l’estate precedente, passando 10 giorni di campeggio impegnato in un’unica e molto soddisfacente attività, che occupava tutte le notti e gran parte dei giorni.
Parliamoci chiaro: aver vinto un simile concorso bastava di per sé. A un’età in cui non sai ancora bene chi sei, è una delle prime prove ufficiali, oggettive, che il mondo si è accorto di te e ti apprezza: è una misura di valore non banale, attorno ai 20 anni. Raccomandato o no – io non lo ero – stai cominciando a distinguerti, e rispetto ai tristi soldati semplici che oziano tutto il giorno in qualche piazza d’armi, aspettando che gli passi, ti stagli proprio. La prova è che verrai pagato, e nemmeno tanto poco. Alzi la mano chi non ha provato il concorso anche per i soldi, oltre che per il brivido del comando.
Ci avete mai pensato? La prima cosa che accomuna un gruppo di allievi ufficiali è avere una motivazione. Che sia il potere, il prestigio, il denaro, la difesa della Patria o una combinazione di tutto questo, l’auc si sente in dovere di dimostrare che merita di stare dov’è. Questo denominatore comune, questo senso di tensione verso un obiettivo, è molto più forte della camerata, sezione o batteria di appartenenza. Queste cose verranno dopo, ad aggiungere dei distinguo, ma il primo, originale denominatore è l’impegno. Noi eravamo simili nella buona volontà, nel desiderio di fare bene, oltre a essere riuniti dall’avercela fatta e dalla possibilità di darne dimostrazione. In ogni batteria c’era tanta, ma proprio tanta energia positiva, ottimismo, visione costruttiva.
Arrivai a Roma il 16, col treno della notte da Trieste e uno zaino con l’indispensabile. Tra gli ultimi acquisti, il più importante erano due paia di mutandoni lunghi alla caviglia, rigorosamente di cotone: avevo il terrore della eventuale lana della divisa sulla pelle e – se necessario – li avrei portati anche in agosto. Mi aspettava una giornata con mio cugino finanziere, che mi scarrozzò in lungo e in largo per Roma e mi suggerì di provare nei Carabinieri, decantandomi i benefici del tesserino di ufficiale di pubblica sicurezza e l’onore di una pistola tutta mia. Mi convinse, rendendosi così inconsapevolmente responsabile dei successivi tre anni e mezzo della mia vita e di un sacco di altre cose, come per esempio il fatto che da 30 anni abito a Roma. Il pomeriggio telefonai alla ragazza della vacanza. Ci vedemmo, e scoprii con immenso sollievo che l’addio estivo potevo considerarlo come un semplice arrivederci: avevo quindi già l’agognata ausiliaria, sogno proibito di ogni marmittone, prima ancora di diventare soldato. Il giorno dopo, accuratamente istruito da mia zia su bus provinciali e relative fermate e con in tasca le chiavi della villa dello zio, partii da via Lepanto verso Bracchausen. Quanti miei futuri colleghi erano sullo stesso bus? Non lo so, ma sospettavo giustamente fossero molti. Stava cominciando l’avventura, mentre da solo, sulla corriera, tentavo di figurarmi come fosse la caserma e in che cosa consistesse la scuola.
Il viaggio per Bracchausen mi era noto: l’avevo percorso un anno e mezzo prima, con l’altro mio cugino e la sua ragazza dell’epoca, che – indovinate un po’? – era proprio la mia nuova ausiliaria. Mi sentivo in una botte di ferro, sotto ogni aspetto. Finalmente arrivammo in vista della Montefinale. Non ero preoccupato, bensì davvero assai curioso. In un qualche ufficio mi comunicarono che venivo assegnato al Traino Meccanico, che non avevo la minima idea di cosa fosse. Capii quasi subito che c’era una distinzione rispetto ai Semoventi, grazie all’incontro fortuito con due miei concittadini conosciuti alla selezione di Verona e che – dopo i saluti – mi spiegarono quanto erano stati fortunati a essere assegnati a questa specialità. Nessuno dei due finì poi il corso: uno si ritirò, all’altro vennero problemi psicologici sconfinanti in qualche patologia psichiatrica, per cui fu dimesso.
Non mi ricordo se entrai per la prima volta in camerata prima o dopo aver ricevuto l’equipaggiamento, fatto sta che non ero né tra i primi né tra gli ultimi. Così potei scegliermi con agio una branda che mi aggradava. Alla fine della giornata, i miei compagni erano l’autoctono Iaccarino, il futuro capostecca Castellani, il futuro gufo Castoldi, i “fratellini” Dalla e Fornasari, il futuro frequentemente sbrandato Meazza, il futuro caporale-di-giornata-fisso Corrada, Giannossi “von” Augusta, più altri tre di cui mi ricordo la faccia ma purtroppo non il nome.
Vennero a visitarci i nonni del 113°, non ancora “nemici” ma anzi prodighi di consigli su come ammorbidire gli anfibi e allestire il cubo. E fu in quella circostanza che sentimmo per la prima volta il termine pistro, scoprendo nel contempo che era destinato a noi.
Le prime ore alla Montefinale mi lasciarono un’impressione su tutte: eri entrato in un meccanismo, se non proprio efficiente, almeno lungamente collaudato. Se ti ci fossi saputo adattare, prendendone il meglio e accettandone l’inevitabile peggio, sarebbe filata liscia. Era una situazione del tutto nuova: ti si richiedeva soltanto di fare cose, non di pensare e decidere passo per passo, momento per momento. Non avevi nessuna responsabilità. Paradossalmente, eri infinitamente più libero che in ogni altro contesto, perché nessuno sarebbe mai entrato nel tuo spazio personale. La forzata condivisione dello spazio fisico, cui necessariamente ci si doveva conformare, creava una totale indipendenza psicologica: saresti potuto restare muto (e non automaticamente anche pentito, contrito e rassegnato) per giorni e settimane, senza che nessuno obiettasse. Io provai immediatamente questa liberazione dalle continue necessità di scelta (dove andare, cosa fare, quando mangiare…), perché mi sentivo guidato come in un gregge, ma senza che il “pastore” pronunciasse un giudizio di merito. Quindi avevo – e da quel momento avrei sempre avuto, durante il corso – tutto il tempo che volevo e mi serviva per pensare, osservare, formarmi opinioni. E potevo scegliere liberamente se e con chi aggregarmi, temporaneamente o in misura più continuativa, senza che ciò dovesse necessariamente definire legami e impegni.
Sì, personalmente ho vissuto l’intera esperienza del corso come un periodo di grande libertà, che mi permetteva di guardarmi intorno “senza essere visto”. L’unica cosa che serviva – e al tempo avevo in abbondanza – era l’energia fisica per marciare, svegliarmi presto, fare le file a mensa. Tutto questo fu chiaro sin dalle prime ore, mentre si formava la camerata di cui risultai uno dei più anziani, e si chiarì ulteriormente nei primi giorni. E quando il mio modo di pormi rispetto al corso venne riassunto nel Numero Unico del 114°, dove alla voce “Burlini” qualcuno scrisse “Chi fa da sé fa per tre”, trovai – allora come oggi – che mi era stato fatto uno dei più bei complimenti che abbia mai ricevuto.