
 Sarei morto, lo sapevo. Le istruzioni dicono di tenere saldamente la tigre per la coda, se l’hai presa. Ma non dicono cosa fare quando alla tigre ci stai sopra. Io ero sopra qualcosa di più pericoloso, che aveva capito che la stavo sfidando. Se io avevo la mia adrenalina, l’Altalena aveva qualcosa che forse stava nelle pieghe delle equazioni di Akundjanov, forse no. Di equazioni sapevo poco, ma mi resi conto che l’accelerazione era aumentata. “Aprite i quaderni e scrivete: sopra i 180 gradi, la Grande Altalena accelera di più”. Avete scritto? Di un balzo mi trovai di almeno altri 10 gradi più in alto, e calcolai che in tre-quattro oscillazioni sarei arrivato dove oltre non si poteva andare. Ero completamente frastornato, ottenebrato, confuso. Tutto ruotava e oscillava, tutto vibrava, tutto ululava. Velikie Kacheli era arrabbiata. Mi scaraventò in basso, mentre a occhi chiusi mi tenevo disperatamente alle aste. A cinque metri da terra sentii un rumore come di pallottola: ero io, la pallottola, che spostavo l’aria che andava a sbattere contro i montanti, restituendomi quel sibilo. Salii verso il cielo, sempre più in alto e sempre più piano. Mi fermai un attimo, poi lanciai un ruggito e spinsi ancora con le gambe. Fui proiettato di nuovo verso il basso dalla furia del meccanismo. Chiusi di nuovo gli occhi, chiedendomi se chi aveva testato la resistenza della mia corda da arrampicata aveva pensato alla mia situazione. Decisi che no: non ci aveva pensato. Appena cominciai a decelerare, riaprii gli occhi. Risalii fino al di sopra di ogni sopra, aspettando di fermarmi. E quando mi fermai, gridai di nuovo e ributtai le gambe in avanti, con rabbia. Ero ad almeno 210 gradi. Vuoi giocare, figlia di troia? Giochiamo! Scesi come un cacciabombardiere in picchiata. Le aste suonavano: una nota sempre più acuta. Dovevo avere le guance dietro le orecchie, ammesso che non le avessi già perse, le orecchie. Ma no: sentivo tutta una gamma di sibili, cigolii, venti e tempeste, cascate del Niagara, Troni e Dominazioni.
Sarei morto, lo sapevo. Le istruzioni dicono di tenere saldamente la tigre per la coda, se l’hai presa. Ma non dicono cosa fare quando alla tigre ci stai sopra. Io ero sopra qualcosa di più pericoloso, che aveva capito che la stavo sfidando. Se io avevo la mia adrenalina, l’Altalena aveva qualcosa che forse stava nelle pieghe delle equazioni di Akundjanov, forse no. Di equazioni sapevo poco, ma mi resi conto che l’accelerazione era aumentata. “Aprite i quaderni e scrivete: sopra i 180 gradi, la Grande Altalena accelera di più”. Avete scritto? Di un balzo mi trovai di almeno altri 10 gradi più in alto, e calcolai che in tre-quattro oscillazioni sarei arrivato dove oltre non si poteva andare. Ero completamente frastornato, ottenebrato, confuso. Tutto ruotava e oscillava, tutto vibrava, tutto ululava. Velikie Kacheli era arrabbiata. Mi scaraventò in basso, mentre a occhi chiusi mi tenevo disperatamente alle aste. A cinque metri da terra sentii un rumore come di pallottola: ero io, la pallottola, che spostavo l’aria che andava a sbattere contro i montanti, restituendomi quel sibilo. Salii verso il cielo, sempre più in alto e sempre più piano. Mi fermai un attimo, poi lanciai un ruggito e spinsi ancora con le gambe. Fui proiettato di nuovo verso il basso dalla furia del meccanismo. Chiusi di nuovo gli occhi, chiedendomi se chi aveva testato la resistenza della mia corda da arrampicata aveva pensato alla mia situazione. Decisi che no: non ci aveva pensato. Appena cominciai a decelerare, riaprii gli occhi. Risalii fino al di sopra di ogni sopra, aspettando di fermarmi. E quando mi fermai, gridai di nuovo e ributtai le gambe in avanti, con rabbia. Ero ad almeno 210 gradi. Vuoi giocare, figlia di troia? Giochiamo! Scesi come un cacciabombardiere in picchiata. Le aste suonavano: una nota sempre più acuta. Dovevo avere le guance dietro le orecchie, ammesso che non le avessi già perse, le orecchie. Ma no: sentivo tutta una gamma di sibili, cigolii, venti e tempeste, cascate del Niagara, Troni e Dominazioni.
E poi.
Fui colpito da un altro fulmine. Persi la presa sulle aste, e fui scaraventato indietro. L’imbragatura tenne. Ero disteso, col sedere sempre sul seggiolino, a occhi chiusi. Non so come potessi restare in equilibrio, ma ero ancora lì. La Grande Altalena mi stava facendo salire per il mio ultimo viaggio, la mia nemesi. E, salendo, il mio cervello si aprì a nuove cose.
Sentivo le aste suonare, ma adesso capivo il suono. Sentivo il vento fischiare, ma adesso capivo il vento. Sentivo l’Altalena salire, ma adesso capivo l’Altalena. Era semplice, davvero molto semplice. Perché non ci ero arrivato prima? Ancora pochi attimi, e Velikie Kacheli mi avrebbe mostrato ciò per cui era stata fatta. Non avevo fretta, mentre salivo a comprendere il Tempo del Mondo.
Non so cosa vide San Pierpaolo dall’alto dei cieli. Forse un fine-corsa alla sua maniera. Forse no. Non importa, davvero.
In tutta la vicenda, avevo commesso un solo vero errore, peraltro giustificabile. Del resto, ero in buona compagnia. Un geniale fisico, allievo nientemeno che di Landau, aveva commesso il mio stesso errore, almeno all’inizio. Poi probabilmente Akundjanov aveva scoperto che qualcosa non andava, non poteva proprio andare. Alla fine aveva capito (e con lui i suoi pastori), proprio come avevo capito io.
Akundjanov, mio fratello. I pastori, miei fratelli. Certamente tutti morti, adesso. Sono passati quasi trent’anni. Ma anche loro sono scesi dall’Altalena, come ho fatto io tre giorni fa. Anche loro si sono risvegliati all’ombra di Velikie Kacheli, un po’ storditi. Non so da dove venissero, e quindi non so se andarono a est o a ovest, a nord o a sud. Credo non importi granché: né dove siano andati, né saperlo.
Quando rivenni, ancora disteso, l’Altalena era immobile. Mi sollevai a sedere, sciolsi l’imbrago e scesi a terra, per tornare verso il Barsuki. Dall’Altalena avevo avuto tutto. Senza scherzi: proprio tutto. Compreso il presentimento, mentre salivo verso il fine-corsa, di sapere finalmente dove stavo andando. Oramai non avevo nessuna fretta: non avrebbe avuto senso averne. Dentro di me non c’erano più emozioni o sentimenti, neanche sensazioni. “Se non sai chi sei, osserva l’Altalena”, diceva il detto. Io l’avevo osservata, anche troppo.
Raccolsi con calma il mio zaino, diligentemente posato su una delle piramidi di sostegno, e me lo infilai sulle spalle. Cinque-sei chilometri dal canyon all’andata, cinque-sei chilometri per il canyon al ritorno. Tutto a posto, no? Oh sì, tutto a posto, certo! Non sapevo se fosse mattina o pomeriggio, ma il sole era alto. Mi voltai indietro solo dopo un paio di chilometri, per controllare se Lei fosse ancora al suo posto. C’era.
Un momento prima di entrare nel canyon mi voltai ancora: Lei non si era mossa. A quella distanza, sembrava proprio un traliccio per il petrolio.
Attraversai lo strano canalino senza vento, e poi il canalone grande. Non c’era motivo di chiedersi dove fosse mai Ahmanov: era una domanda stupida. Presentimenti.
Non sapevo cosa avrei visto, una volta uscito nel Barsuki. Non sapevo neanche se avrei visto qualcosa, ma tutto si concretizzò non appena girai gli occhi verso nord.
In mezzo al deserto, a molti chilometri da me, c’era qualcosa. Anche questo qualcosa, come giorni prima l’Altalena, vibrava al calore dell’aria: sembrava liquido.
Mi sedetti, con calma. Non avevo fame, non avevo sete; ma dovevo mangiare e bere, e così feci.
Poi mi incamminai, sempre con molta calma, verso il qualcosa.
Impiegai due ore solo per poterlo distinguere meglio. Dopo un’altra ora ci ero – si può dire – vicino. Un catafalco.
Ero sicuro che non l’avessero costruito in una notte, mentre io ero a dondolarmi: sembrava quadrato, e doveva avere più o meno un chilometro di lato. Man mano che mi avvicinavo, le pareti laterali si palesarono per quel che erano: lunghi tendaggi neri, alti una decina di metri. Erano inchiodati sopra, sul pavimento della struttura, ma non sotto, e perciò sbattevano al vento. Strano: c’era solo una brezza leggera, e come poteva quel semplice vento agitare simili paramenti?
Giunsi a ridosso della smisurata piattaforma. I teloni erano di un materiale simile alla juta, ma più spesso. Neri, a parte la polvere e la sabbia. E vecchi: oh, sì! antichi. Verso est, quello che sembrava un palo saliva dal piano del catafalco per un’altezza difficile da calcolare, ma che poteva essere di un centinaio di metri. Mi incamminai in quella direzione, accompagnato dai tuoni dei teloni che ondeggiavano. Arrivai sotto quella sorta di incomprensibile obelisco, svolsi la mia corda, agganciai il palo e mi issai. Le assi che ricoprivano il catafalco erano dello stesso colore del palo: un marrone chiaro con sfumature di grigio. Mi chiesi se fossero più o meno antiche del seggiolino dell’Altalena, ma sapevo che era una domanda senza senso. Mi sedetti con la schiena appoggiata all’obelisco. Dovevo fare l’ultimo esperimento, che in realtà era una verifica pro forma: ero pronto a scommettere qualsiasi cosa sul risultato.
Tirai fuori il telefono satellitare e provai ad accenderlo. Non funzionava. Cioè no: funzionava benissimo, solo che non trovava alcun segnale, come previsto. E credevo proprio di sapere il perché.
——————–°———————
Devo proprio decidermi. Non posso stare qui ancora per molto: le razioni K si stanno esaurendo. Sono due giorni che sto seduto su queste vecchie assi, con lo sbattere dei teloni nelle orecchie, ad aspettare. Ho esplorato il catafalco: qui sopra non c’è niente, niente di niente. Credo sia una metafora del deserto; e non solo di quello, temo.
Ieri notte ho guardato le stelle: non ne ho riconosciuta nessuna. Chissà se Akundjanov conosceva le stelle. Chissà se lui o i suoi pastori, nel giugno o luglio di quasi trent’anni fa, hanno alzato gli occhi, per scoprire che il cielo era cambiato.
In questi due giorni ho ripensato a tutta la storia. Ho pensato al mio unico errore. Avevo sentito parlare di un’altalena, mi sono messo alla ricerca di un’altalena, ho creduto di trovare un’altalena. Beh, assomigliava proprio a un’altalena, no?
Che strano. Ci ero andato più vicino proprio all’inizio, quando avevo visto le foto del Wat suthat. Quel coso di tek rosso poteva essere qualsiasi cosa, oltre che un’altalena. Anche una porta, ricordo di aver pensato. Già, una porta.
Ho pensato molto anche ad Akundjanov. Quanto darei per averlo conosciuto, per poter parlare con lui! Un genio assoluto, un intuito incredibile, una modestia senza pari. I russi sono russi, nel bene e nel male. Il nostro errore era simile, ma non identico: lui, da fisico, semplicemente aveva affrontato il problema secondo una prospettiva troppo limitata, quella termodinamica. Finché non si è accorto che non poteva essere. Non occorreva riscrivere i manuali: erano giusti. Ma anche per lui, quando l’ha scoperto era troppo tardi. Di qua o di là del canalone ci devono essere ancora le sue ossa: gli errori si pagano.
Stamattina, al risveglio, ho scoperto che nel sonno avevo preso una decisione. L’Altalena mi ha portato qui, l’Altalena forse può riportarmi indietro. Domani torno a trovare Velikie Kacheli, per vedere se mi offre un altro giro. Prima di salirci avrei dovuto comprare un biglietto di andata e ritorno, ma non ci ho pensato. Ma adesso resto qui ancora un poco: sono stanco, molto stanco. Domani.
L’orologio mi dice che sono le due del pomeriggio. Può darsi.
I miei appunti dicono che sono nel bel mezzo del Barsuki. Ah, sì?
Non so. So solo che sono in un dove e in un quando, spazio duale, Tempo del Mondo.
Fine delle informazioni.




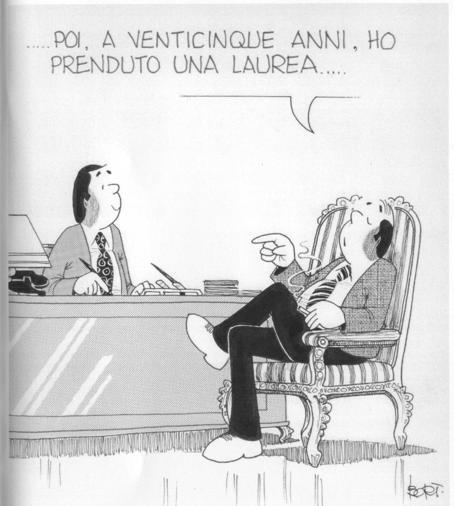
Bellissima.